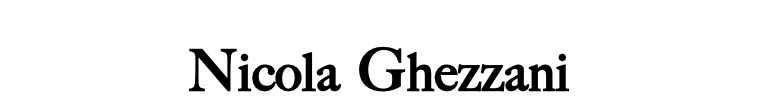Autolesionismo
Il bisogno di farsi del male
Glossario: Autolesionismo. La parola autolesionismo deriva dal greco autòs, se stesso, e dal latino ledere, ferire. Essa indica l’atto attraverso il quale un individuo si procura intenzionalmente del male, sia in senso fisico che in senso morale.
Difese dal legame
 «Tu non puoi più farmi del male!» Quante volte abbiamo sentito l’amante deluso urlare questa frase al suo oggetto d’amore, divenuto per qualche rovescio della sorte il suo peggior nemico. Soggiogato e portato alla sofferenza dalla dinamica amorosa, l’innamorato rinnega il proprio amore, lo respinge e lo ripudia, allo scopo di difendersi.
«Tu non puoi più farmi del male!» Quante volte abbiamo sentito l’amante deluso urlare questa frase al suo oggetto d’amore, divenuto per qualche rovescio della sorte il suo peggior nemico. Soggiogato e portato alla sofferenza dalla dinamica amorosa, l’innamorato rinnega il proprio amore, lo respinge e lo ripudia, allo scopo di difendersi.
La dinamica della sofferenza d’amore – del tutto evidente nel caso dell’innamorato compulsivo, sacrificale o comunque deluso – è una possibilità implicita in tutti i legami di alta intensità sentimentale. Nasce con la stessa nascita biologica e psicologica dell’essere umano: l’esistenza individuale è legata agli stati soggettivi di bisogno e alla loro soddisfazione, e tutti gli stati di bisogno si traducono, prima o poi, in quelle complesse strutture di dipendenza e interdipendenza che chiamiamo amore.
La sofferenza d’amore, così palese nelle età adulte, nasce già organizzata con gli stessi legami primari, i legami che il bambino contrae con i genitori e i primi care givers, i portatori di cura. Come dimostrano gli studi sulla dipendenza primaria, come quelli di René Spitz1, John Bowlby2 e Mary Ainsworth3 e sull’empatia primaria, come per esempio quelli di Colwyn Trevarthen4, la relazione di accudimento necessita di intimità empatica basata su una piena reciprocità, e della sua profonda interiorizzazione. E poiché la relazione primaria è indispensabile per la soddisfazione dei bisogni vitali, la sua perturbazione può causare angoscia di perdita e traumi da abbandono e maltrattamento: in sostanza, sofferenza d’amore.
Poiché nella relazione di dipendenza è impossibile non soffrire almeno un po’, esistono difese specifiche di cui ogni neonato ed ogni bambino dispongono: il pianto, la rabbia, l’isolamento. In età adulta, la sofferenza d’amore può essere provocata quando a una dinamica seduttiva segue il maltrattamento attivo volontario o provocato da codici relazionali improntati alla durezza o allo sfruttamento. Il partner può essere un egoista, un narcisista, un sadico sfruttatore oppure essere condizionato alla durezza relazionale da un sistema di valori che gliela impone. Per il partner vittima di queste dolorose dinamiche, una delle difese più ricorrenti è la negazione della dipendenza.
Irraggiungibile in termini assoluti perché nessuno può fare a meno di altri esseri umani, la negazione della dipendenza si può perseguire solo per gradi e secondo modalità e stili soggettivi, quindi in termini relativi: secondo un ventaglio di possibilità che va da un estremo del controllo dell’altro fino all’estremo opposto del controllo di sé.
Se la difesa si polarizzata sulla fantasia del controllo dell’altro, prima o poi genererà il mito della simbiosi, nel quale il controllo è ottenuto massimizzando la dipendenza reciproca e fondendo le due identità. Il modo più immediato e spontaneo di controllare la rabbia o la perdita dell’altro è stringerlo a sé: il pianto del bambino ha questo scopo: indurre allarme, dolore e colpa nell’adulto e costringerlo alla simbiosi.
L’altra modalità di difesa dalla sofferenza d’amore è l’isolamento emotivo. Se passa attraverso fasi più o meno lunghe di rabbia frustrata, il bambino scopre che, isolandosi nel suo mondo interno, può estinguere il dolore. Su questa linea, l’adulto che si polarizza sulla fantasia difensiva del controllo di sé, viene affascinato dal mito dell’autosufficienza, nel quale mostra a se stesso di poter fare a meno di chiunque. Il mito dell’autosufficienza presuppone una fantasia di invulnerabilità che sarà perseguita di fatto grazie ad un’azione calibrata e incrementale di insensibilità. La persona che si vuole libera dalla dipendenza controllando se stessa farà di tutto per diventare insensibile.
Se osserviamo gli stili di difesa dalla dipendenza spostati verso il polo del controllo di sé, quindi sulla pratica della insensibilità, possiamo vedere che una delle modalità oggi più diffuse ed efficaci è la contro-dipendenza, per la quale ho coniato le categorie della anoressia sentimentale e della autarchia affettiva5. Il controdipendente si attesta su una posizione di sufficienza rispetto all’amore, talvolta secondo modalità neutre e distanti, talaltra – scivolando verso la simbiosi – attraverso maltrattamenti attivi.
Una forma impressionante di psicopatologia collegata a questa modalità difensiva sono i disturbi alimentari di tipo anoressico, nei quali il controllo dell’appetito e dell’aumento ponderale rappresentano lo sforzo dell’individuo di espellere da sé il bisogno fisiologico alimentare, inteso come debolezza e, in termini simbolici, il bisogno della relazione umana conviviale. Non a caso, spesso il disturbo alimentare di tipo anoressico coincide con il controllo degli affetti e delle dipendenze, quindi con l’anoressia sentimentale.
Un’altra dinamica di difesa vicina al polo del controllo di sé, dinamica più rara, benché in rapida espansione a livello giovanile soprattutto femminile, è la sofferenza auto-inferta: l’autolesionismo.
Fenomenologia e significato del sintomo
 La ricerca dell’invulnerabilità attraverso la pratica dell’insensibilità corporea e del rifiuto di ogni compassione per se stessi è una delle più drammatiche avventure della psiche umana. Frutto di sofferenze antiche e recenti causate da genitori rigidi e ossessivi o anche persecutori o da contesti educativi sadici e umilianti, il desiderio d’essere insensibile può produrre un inquietante paradosso. Giovani poco più che adolescenti, soprattutto ragazze, ma anche donne adulte, si provocano tagli in ogni parte del corpo mediante lamette, forbici o coltelli, si bruciano con cicche di sigarette, si fasciano i seni fino a farli dolere, si costringono a regimi dietetici spietati o a ingoiare cibi disgustosi inducendosi sofferenza.
La ricerca dell’invulnerabilità attraverso la pratica dell’insensibilità corporea e del rifiuto di ogni compassione per se stessi è una delle più drammatiche avventure della psiche umana. Frutto di sofferenze antiche e recenti causate da genitori rigidi e ossessivi o anche persecutori o da contesti educativi sadici e umilianti, il desiderio d’essere insensibile può produrre un inquietante paradosso. Giovani poco più che adolescenti, soprattutto ragazze, ma anche donne adulte, si provocano tagli in ogni parte del corpo mediante lamette, forbici o coltelli, si bruciano con cicche di sigarette, si fasciano i seni fino a farli dolere, si costringono a regimi dietetici spietati o a ingoiare cibi disgustosi inducendosi sofferenza.
Si tratta di una psicopatologia più diffusa di quanto non si pensi, che unisce il masochismo fisico (il piacere di farsi o di farsi fare del male) a un individualismo estremo e solitario, di carattere difensivo.
Una mia paziente, sin dal primo contatto via e-mail, descrive con precisione la funzione difensiva dell’autolesionismo come isolamento e rivendicazione autarchica di controllo su di sé:
Mi sembra che tutto sia cominciato intorno ai 16 anni, quando ho cominciato a sentire dentro di me una strana sensazione, come di disagio, una velata malinconia. Il rapporto con i miei genitori non è mai stato dei migliori. O meglio, in famiglia non ci sono gravi problemi ma a volte litigavo di brutto con i miei, soprattutto con mia madre, che ha una visione della vita diametralmente opposta alla mia. Poi per altri motivi (amicizie, mancanza di amori, e altre cose), ho cominciato a sentirmi triste, sempre, ovunque e comunque.
Questi «sfoghi» sul mio corpo non sono mai seguiti a delle liti, non sono mai stati degli sfoghi di rabbia immediata. Mi ritrovavo magari a graffiarmi con le unghie dei piccoli brufoletti o imperfezioni che sentivo sulle braccia o sulle gambe, cose che mi hanno sempre dato fastidio e irritato, e da lì mi provocavo tante piccole ferite, tanti piccoli graffi, ma tutto ciò di solito avveniva in momenti in cui non avevo pensieri per la testa oppure quando mi sentivo… non so… stufa di tutto. Ciò accade anche oggi. Quando sento dentro di me come un insostenibile fardello e non ho voglia di fare niente, allora comincio a stuzzicarmi. Odio sentire le croste dei graffi sul mio corpo, sicché mi graffio nuovamente per toglierle… Inutile dire che mia madre ha sempre trovato le mie magliette piene di macchie di sangue, ma mi dice semplicemente che s’è rotta le scatole di lavarle, non che le importi qualcosa del mio malessere.
 La giovane autolesionista è molto esplicita: dapprima c’è una tristezza di tipo depressivo, che potrebbe spingerla a chiedere contatto affettivo a qualcuno, a cercare un senso della vita al di fuori della sua stanza, del suo isolamento, o anche indurla a protestare nei confronti del mondo in cui vive. Questa tristezza tuttavia urta contro la barriera di una delusione, di una mancanza di fiducia in sé e negli altri. Scatta allora il rifiuto della relazione. Da quel momento, si avvia come per forza d’inerzia la pratica autolesionista: la ricerca di dolore, la sensibilità autoreferenziale, talvolta l’imbruttimento del corpo.
La giovane autolesionista è molto esplicita: dapprima c’è una tristezza di tipo depressivo, che potrebbe spingerla a chiedere contatto affettivo a qualcuno, a cercare un senso della vita al di fuori della sua stanza, del suo isolamento, o anche indurla a protestare nei confronti del mondo in cui vive. Questa tristezza tuttavia urta contro la barriera di una delusione, di una mancanza di fiducia in sé e negli altri. Scatta allora il rifiuto della relazione. Da quel momento, si avvia come per forza d’inerzia la pratica autolesionista: la ricerca di dolore, la sensibilità autoreferenziale, talvolta l’imbruttimento del corpo.
L’effetto è che la ragazza si isola (il dolore contrae l’Io; la sensibilità chiusa nell’Io esclude sempre di più la relazione col mondo; l’eventuale imbruttimento genera vergogna e bisogno di nascondersi), e cessa di desiderare un contatto ritenuto inutile.
Detta autolesionismo nel linguaggio comune, questa patologia viene siglata, nel lessico psichiatrico, come DSHS (Deliberate Self Harm Sindrome, Sindrome da autoferimento intenzionale). Tra le adolescenti e le giovani donne ha ormai raggiunto una diffusione analoga a quella dell’anoressia alimentare e fornisce alla ragazza la stessa ambigua aura di diversità. Adotta tecniche – dal taglio alla bruciatura, dall’abrasione all’escoriazione, dalla flagellazione all’induzione forzata del disgusto – note (per tutt’altri scopi) alle sante dei secoli passati, in una mimesi parodistica della forza di carattere e della virtù.
Ossessionate dai loro rituali che combinano l’esaltazione del autocontrollo col masochismo psichico e fisico, riescono infine a escludersi dalla vita sociale e sentimentale simulando l’inviolabilità e raggiungendo l’insensibilità.
Dice una ragazza affetta da tale disturbo: «Ho capito che lo faccio per allontanare gli altri… Avendo tante cicatrici sul viso e sul corpo, finisco per fare ribrezzo e così mantengo gli altri a debita distanza. In un certo verso la cosa mi rassicura, data la mia paura degli altri. E’ come se fosse una «barriera di protezione». In sostanza il motto dell’autolesionista potrebbe essere: «Sono io a farmi del male, non tu!»
Si tratta dunque di una patologia dell’identità non solo affettiva, ma anche sociale e di genere, caratteristica di donne giovani e insicure. Poiché il suo stile è solitario anche quando appare in gruppo, essa andrebbe sottratta alla solitudine e affidata alle cure della psicoterapia e, laddove possibile, dovrebbe essere accolta in gruppi di Auto Aiuto, perché si sviluppi un’identità femminile matura, capace sia di autonomia che di relazione.
Strutture psicopatologiche
 Ovviamente, la DSHS è una sindrome che va incontro a diverse strutturazioni psicopatologiche. Come ho argomentato nei miei libri, e in questo sito alla voce Le strutture psicopatologiche, ogni sindrome può aggravarsi e attraversare diverse organizzazioni della personalità: esiste una DSHS ansiosa, nella quale il sintomo interviene per placare il sopraggiungere di un’ansia irragionevole e di un’oscura angoscia; una DSHS ossessiva, nella quale il sintomo pone rimedio alla sensazione di ospitare impulsi mostruosi; esiste una DSHS isterica, nella quale il sintomo interviene durante o più spesso dopo un litigio; una depressiva, allorché la pratica si inserisce in un mood triste, talvolta desolato, aggravandolo.
Ovviamente, la DSHS è una sindrome che va incontro a diverse strutturazioni psicopatologiche. Come ho argomentato nei miei libri, e in questo sito alla voce Le strutture psicopatologiche, ogni sindrome può aggravarsi e attraversare diverse organizzazioni della personalità: esiste una DSHS ansiosa, nella quale il sintomo interviene per placare il sopraggiungere di un’ansia irragionevole e di un’oscura angoscia; una DSHS ossessiva, nella quale il sintomo pone rimedio alla sensazione di ospitare impulsi mostruosi; esiste una DSHS isterica, nella quale il sintomo interviene durante o più spesso dopo un litigio; una depressiva, allorché la pratica si inserisce in un mood triste, talvolta desolato, aggravandolo.
C’è poi una DSHS maniacale, nella quale il sintomo è accompagnato da intensi vissuti di bellezza estatica e di esaltata unione con un amore, un sentimento, il cosmo ecc. Il gesto può essere accompagnato allora da una confessione disarmante: «Non posso farci niente, devo farlo. È più forte di me. Mi piace troppo!».
In altri casi, molto più rari, c’è un esito nella perversione, e allora l’odio per la vita e per la stessa natura umana prende il sopravvento, la componente depressiva vira e la persona dice: «Col dolore mi metto dall’altra parte della vita, dove sono solo e odio gli altri esseri umani».
E c’è anche un autolesionismo borderline, di cui parla con estrema competenza Marsha Linehan (2020), nel quale l’impulso aggressivo, la rabbia esplosiva, vengono deviati contro il proprio corpo e lo stordimento che ne consegue sortisce un effetto di paradossale rabbonimento. Nell’autolesionismo borderline non c’è alcuna raffinatezza, c’è l’atto bruto inteso ad annullare il dolore per sfinimento, mettere a repentaglio l’incolumità fisica, sforare il confine della morte. Quando la strutturazione borderline confina con una estrema maniacalità o una intensa depressione non è da escludere la possibilità che col gesto si consumi un suicidio, spesso impulsivo e incidentale, talvolta invece avvolto nella desolazione depressiva e quindi più o meno volontario.
Esiste infine anche un autolesionismo psicotico, ma eccede i limiti di questo scritto. Nella psicosi si ripercorrono tutti i livelli della strutturazione psicopatologica, con un accentuazione sempre più delirante.
L’autolesionismo come espressione del senso di colpa
 La causa psicodinamica dell’autolesionismo non è, dunque, da ascrivere soltanto alla fantasia di controllare il legame, non è soltanto espressione del bisogno di opposizione. Esiste un’ampia casistica di persone che feriscono per darsi un sollievo dai sensi di colpa. In questi casi, il bisogno di integrazione sociale si manifesta come impulso all’espiazione e alla riparazione delle proprie colpe, vere o presunte, mediante una punizione fisica.
La causa psicodinamica dell’autolesionismo non è, dunque, da ascrivere soltanto alla fantasia di controllare il legame, non è soltanto espressione del bisogno di opposizione. Esiste un’ampia casistica di persone che feriscono per darsi un sollievo dai sensi di colpa. In questi casi, il bisogno di integrazione sociale si manifesta come impulso all’espiazione e alla riparazione delle proprie colpe, vere o presunte, mediante una punizione fisica.
Una paziente mi illustrò con chiarezza questa possibilità adoperando queste parole: «Se mi chiedessero perché pratico autolesionismo risponderei che lo faccio per punirmi, per ferire quella bestia cattiva che a volte si impossessa di me e che non so come scacciare. Mi ferisco perché ho bisogno di punirmi e il dolore fisico allontana momentaneamente quello psicologico permettendomi un po’ di tregua».
Io le risposi: «Mi rendo conto della sua necessità di ferirsi e di punirsi, eppure dobbiamo cominciare a pensare che la punizione auto-controllata col tempo diventa un rito e impedisce di capire quale sia l’origine del senso di colpa. Che abbia torto o ragione, il senso di colpa deve sempre essere messo al vaglio della coscienza. Punirsi per principio significa non permettere ai sensi di colpa di fare il loro lavoro, che è quello di interrogarsi non solo sui propri comportamenti, ma anche sulle proprie tendenze caratteriali, e capire se esse meritano il severo giudizio di condanna. Si chieda perché è in colpa e cosa eventualmente può fare per rimediare. In terapia dovremmo cominciare a pensare in questi termini: la punizione non va messa in atto – anche se in una fase iniziale può essere tollerata. Piuttosto, bisogna risalire ai motivi che hanno scatenato il senso di colpa e agire per risolverli».
Se vogliamo guarire questo tipo di persona, è necessario e imprescindibile farle capire che il suo autolesionismo è espressione sia di una rabbia impensabile che di un senso di colpa inconscio, conseguente a quella rabbia. Quindi che essa è un’espressione di masochismo morale – come ho argomentato nel mio libro Volersi male6, che tuttavia ha assunto la strategia dissociativa dell’azione impulsiva.
Col tempo, la pratica dell’autolesionismo a fini punitivi può trasformarsi da impulsiva e occasionale a costante, ritualizzata, persino condivisa a livello di coppia, fino a divenire una trasgressione erotica, nella quale prevale il sentimento di complicità e l’impulso amoroso, oppure una perversione morale, nella quale prevale sempre di più l’elemento emozionale dell’odio per la vita.
Come tutte le perversioni, può dare l’idea dell’autocontrollo; in realtà implica sempre la cancellazione dei moventi originari del bisogno di soffrire e l’impossibilità di affrontare una libera e matura riflessione morale.
Autolesionismo e introversione
 L’autolesionismo coincide infine con l’affermazione estrema di una personalità ipersensibile, ma anche introversa e talvolta solitaria, che radicalizza questi suoi tratti allo scopo di non dipendere da nessuno. La fantasia di escludere gli altri dal proprio mondo è forte e chiara sia quando si afferma con orgoglio la propria pratica, sia quando ci si vergogna di essa e la si intuisce collegata all’autoumiliazione e al senso di colpa.
L’autolesionismo coincide infine con l’affermazione estrema di una personalità ipersensibile, ma anche introversa e talvolta solitaria, che radicalizza questi suoi tratti allo scopo di non dipendere da nessuno. La fantasia di escludere gli altri dal proprio mondo è forte e chiara sia quando si afferma con orgoglio la propria pratica, sia quando ci si vergogna di essa e la si intuisce collegata all’autoumiliazione e al senso di colpa.
L’autolesionista è spesso una persona altamente sensibile, sia estroversa che introversa. Ha doti empatiche estreme, che in terapia si scopre essere state oggetto di un sequestro relazionale: una madre intrusiva, una famiglia iperprotettiva, un ambiente moralistico onnipresente dominano l’inconscio emozionale del paziente. Memorie di traumi o di insopportabili umiliazioni premono alle porte della coscienza. Il dolore morale è allora insopportabile, perché insopportabile è il conflitto che potrebbe scatenarsi. La persona altamente sensibile non regge al peso del conflitto e preferisce dissociarsene7. A questo scopo, il passaggio dal dolore mentale a quello fisico provocato comporta un abbassamento della tensione aggressiva e un sollievo dall’angoscia di colpa.
L’autolesionista considera la sofferenza come un dato esistenziale non solo ineludibile, ma anche inevitabile e costante (e in ciò, come ho detto, rivela una certa disposizione alla depressione e al masochismo morale); ma proprio pertanto tale sofferenza deve essere amministrata per intero dal suo Io. L’autolesionista non sopporta che la sofferenza – che colora per intero la sua vita – possa derivargli o essergli imposta da qualcun altro. Egli deve infliggersela da sé: secondo modalità e gradi che la sottraggano alla casualità esteriore e la conducano e la confinino nell’ambito della scelta soggettiva. «Mi do la sofferenza che voglio», dice il soggetto autolesionista. «Poiché la vita è sofferenza, sarò io, non tu, a decidere di infliggermela!»
Spesso questa patologia, soprattutto quando si manifesta in fase giovanile, coincide con il rifiuto di una condizione di vita ipercontrollata e iperprotetta, caratteristica di famiglie che sorvegliano la morale dei comportamenti dei figli o proteggono il loro corpo custodendolo come un valore sacro. Purtroppo, queste famiglie ignorano o mistificano l’esistenza di una sensibilità e di una psiche meritevoli di attenzioni quanto e più dei comportamenti esteriori e del corpo. In questo caso, il giovane autolesionista “gusta” la sofferenza come un viatico alla consapevolezza di possedere un mondo interno, non solo un corpo esteriore dominato dagli altri.
Altre volte, l’autolesionismo coincide con una condizione di indigenza o di marginalità nella quale la società – quella che ho chiamato, sulla scorta degli studi di Illich, la “società terapeutica” o “società anestetica”8– impegnata nel valore dell’assistenza fisica, viene ripudiata con odio sulla base della sua inettitudine a coltivare i valori della psiche e della sensibilità morale. L’autolesionista, che in questo caso è più impulsivo e conflittuale del giovane sensibile e introverso, si fa del male perché il dolore o il danno autoinferto lo “risvegliano” e gli restituiscono la sensazione di una proprietà di sé.
L’autolesionismo come tendenza epocale
 Intesa come protesta di categoria (di alcune frange giovani o di marginali) l’autolesionismo da solitario e nascosto è diventato un fenomeno trendy, di tendenza, e come tale esibito, almeno nei suoi stili e nei suoi risultati ultimi. Da ultimo ha invaso il Web, dove siti giovanili immortalano con selfie e testimonianze le macabre scene di una cultura condivisa. Ferirsi, sballarsi, abbrutirsi, mettersi a rischio è diventata ormai una sorta di perversione globale.
Intesa come protesta di categoria (di alcune frange giovani o di marginali) l’autolesionismo da solitario e nascosto è diventato un fenomeno trendy, di tendenza, e come tale esibito, almeno nei suoi stili e nei suoi risultati ultimi. Da ultimo ha invaso il Web, dove siti giovanili immortalano con selfie e testimonianze le macabre scene di una cultura condivisa. Ferirsi, sballarsi, abbrutirsi, mettersi a rischio è diventata ormai una sorta di perversione globale.
Coltivato come una forma di moda e di comunicazione interpersonale, l’autolesionismo non è allora più da considerare una semplice psicopatologia bensì una forma complessa di trasgressione morale, gli strumenti della cui risoluzione dovranno pertanto essere non solo psicologici ma anche di carattere psico-sociale, politico e culturale.
La patologia rivela, dunque, una grave lacuna culturale: la società attuale si mostra esperta nella gestione medica delle persone (sacralizzando il concetto di salute del corpo e di amore di sé), di fatto però fingendo di ignorare che la salute del corpo è un effetto della sua libertà; e che la libertà del corpo coincide sempre con una coscienza personale in grado di opporsi ai condizionamenti sociali, di integrare regole condivise e di sviluppare una personalità tanto autonoma quanto conviviale.
In sintesi, ciò che manca al giovane autolesionista è il pieno sentimento del diritto di opporsi al dogma sociale della dipendenza dal controllo parentale e della fruizione passiva del benessere fisico. Di conseguenza, il giovane autolesionista manca di strumenti di analisi del malessere psichico, sia personale che collettivo, che potrebbero aiutarlo a guarire. Da una parte la sua famiglia vive immersa in una psicologia di beni e di sicurezze fisiche; dall’altra, la società intorno lo espropria del corpo, per metterlo a servizio del consumo, dell’industria del benessere, delle politiche sociali di assistenza e infine di una psichiatria sempre più totalitaria e coercitiva.
In questo panorama di controllo assoluto dei corpi a tutto sfavore del rispetto per la psiche individuale e la dignità della persona – che comprende il diritto di proprietà sul corpo personale – l’autolesionista gioca la sua partita di resistenza: un lento, inesorabile teatro della violenza e della provocazione.
Il dialogo psicoterapeutico e sociale dovrebbe essere in grado di accettare la sfida dell’autolesionista (il diritto di farsi del male) che egli lancia ai suoi interlocutori. Ma con l’accettazione della sfida, la psicoterapia dovrebbe favorire un ribaltamento dei valori: che si dia parola e dignità alla rabbia e ai dolori sepolti, che si valorizzino i contenuti empatici, sensibili e introversi, che si rafforzi l’identità soggettiva, in modo che il controllo su di sé invocato dalla patologia sia il prodotto di una mente ferma e consapevole, non già la compulsione ossessiva di un sintomo.
Bibliografia
Ainsworth M. D. S., Blehar M.C., Waters E. e Walls S. (1978). Patterns of attachment: A psychological study of the strange situation, Lawrence Erlbaum Associates Publishers, Hilldale.
Bowlby C., Attaccamento e perdita, vol. 1, 2, 3, Bollati Boringhieri, Torino, 1976, 1978, 1983.
Ghezzani N., Volersi male, masochismo, panico, depressione. Il senso di colpa e le radici della sofferenza psichica. FrancoAngeli, Milano, 2002.
Ghezzani N., Autoterapia, Franco Angeli, Milano 2005.
Ghezzani N., Quando l’amore è una schiavitù, Franco Angeli, Milano 2006.
Ghezzani N., La paura di amare, Franco Angeli, Milano, 2012.
Ghezzani N., Il dramma delle persone sensibili, FrancoAngeli, Milano, 2021.
Illich I. (1976), La nemesi medica, Red, Como 1991.
Linehan M. (2020), Una vita degna di essere vissuta, Raffaello Cortina Milano, 2021.
Spitz R.A. (1983), Dialoghi dall’infanzia, Armando, Roma, 2000.
Trevarthen C (1977), Empatia e biologia, Raffaello Cortina, Milano, 1988.
- Spitz R.A. (1983), Dialoghi dall’infanzia, Armando, Roma, 2000.
- Bowlby C., Attaccamento e perdita, vol. 1, 2, 3, Bollati Boringhieri, Torino, 1976, 1978, 1983.
- Ainsworth M,D.S.. Blehar M.C., Waters E. e Walls S. (1978). Patterns of attachment: A psychological study of the strange situation, Lawrence Erlbaum Associates Publishers, Hilldale.
- Trevarthen C. (1997), Empatia e biologia, Raffaello Cortina, Milano, 1998.
- Cfr. Ghezzani N., Quando l’amore è una schiavitù, Franco Angeli, Milano 2006 e id., La paura di amare, Franco Angeli, Milano, 2012.
- Ghezzani N., Volersi male, masochismo, panico, depressione. Il senso di colpa e le radici della sofferenza psichica. FrancoAngeli, Milano, 2002.
- Ghezzani N., Il dramma delle persone sensibili, FrancoAngeli, Milano, 2021.
- Ghezzani N., Autoterapia, Franco Angeli, Milano 2005. Vedi anche Illich I., La nemesi medica, Red, Como 1991.