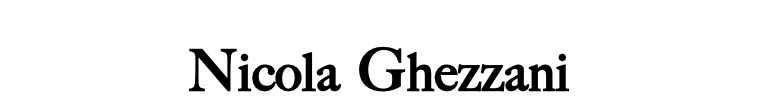L’autostima
Cos’é, come la si perde, come la si riconquista
Cos’è l’autostima e come funziona
 L’autostima consiste nell’opinione che abbiamo di noi stessi, dunque nel giudizio di valore che esprimiamo circa la nostra identità.
L’autostima consiste nell’opinione che abbiamo di noi stessi, dunque nel giudizio di valore che esprimiamo circa la nostra identità.
Il termine stima nasce in contesti sociali di valutazione, nei quali occorre adoperare delle unità di misura per differenziare oggetti e persone, conferendo loro uno specifico valore. Si stima il peso di una merce o il suo valore di mercato; allo stesso modo si stima un essere umano, cioè se ne stabilisce il suo valore intrinseco. Poiché la stima è un atto sociale, il valore di un essere umano deriva sempre da un giudizio sociale interiorizzato, conscio o inconscio, relativo ai molteplici aspetti della persona. Nondimeno, se è oggetto di riflessione autocosciente (come accade in psicoterapia), il giudizio su di sé può essere gestito dall’Io cosciente ed essere quindi un giudizio di valore il più possibile autonomo.
In senso psicologico, la valutazione, la stima, è indirizzata da noi a noi stessi (in questo senso è opportuno parlare di auto-stima), ed è più o meno alta, più o meno positiva.
Come è intuibile, l’autostima non presenta giudizi costanti in nessun essere umano e subisce variazioni nella stessa misura in cui variano gli “umori” – le emozioni e i sentimenti – soggettivi. La sua variabilità dipende da fattori emotivi interni alla soggettività, i quali tuttavia sono sempre influenzati da fattori esterni.
Le circostanze sociali che attivano la nostra autostima – circostanze presenti nella realtà effettiva o immaginaria – possono essere in apparenza tranquille e nondimeno celare fattori più o meno visibili di giudizio negativo stressante. Il giudizio negativo proviene da due aree di significati valoriali, presenti più o meno in tutte le culture e interiorizzati dall’individuo: l’inadeguatezza e la cattiveria; l’inadeguatezza è sanzionata dalla vergogna, la cattiveria è invece sanzionata dal senso di colpa. In entrambi i casi, l’angoscia di non essere all’altezza di uno standard – affettivo, morale, estetico, caratteriale, intellettuale – da raggiungere nel contesto di appartenenza per dimostrare il proprio valore genera uno stress psicofisico specifico, tale da innescare ansie, angosce, sintomi e collassi dell’Io.
Immaginiamo di essere di fronte a persone o a particolari situazioni – sia reali che immaginari – che ci implicano sul piano dell’autostima: ecco che ci osserviamo, ci valutiamo, ci giudichiamo. Se il giudizio che formuliamo su di noi è negativo ed è cosciente, possiamo istigarci a fare meglio o a essere migliori, possiamo controllarci o punirci, oppure semplicemente possiamo andare incontro a un crollo nella vergogna o nella colpa, quindi a un collasso dell’Io.
Non meno spesso, tuttavia, il giudizio negativo è inconscio; allora il disagio non appare alla coscienza, ma si esprime attraverso ansie e angosce apparentemente inesplicabili, nonché con sintomi di ogni ordine.
Nel caso in cui si sviluppi una sintomatologia, la circostanza esteriore ha funzionato come un attivatore e un amplificatore del giudizio negativo che gravita nella mente inconscia, che implica un sentimento di autostima negativa subdolo e latente.
L’immagine di sé
 L’autostima si comincia a costruire nella prima infanzia, in particolare con l’interiorizzazione di giudizi di valore emotivi, talvolta anche verbali, espressi dalle figure adulte di riferimento. Nel tempo, le ripetute esperienze di stima da parte degli altri e di autostima – in parte conseguenti alle valutazioni altrui, in parte autonome, ossia dovute a deduzioni personali – vanno a costituire una memoria auto-valutativa, che può essere più o meno positiva o negativa. Questa memoria influenza costantemente il rapporto con noi stessi, quindi i nostri umori, giungendo ad essere il “filtro” di ogni nostra interazione con noi stessi e con gli altri.
L’autostima si comincia a costruire nella prima infanzia, in particolare con l’interiorizzazione di giudizi di valore emotivi, talvolta anche verbali, espressi dalle figure adulte di riferimento. Nel tempo, le ripetute esperienze di stima da parte degli altri e di autostima – in parte conseguenti alle valutazioni altrui, in parte autonome, ossia dovute a deduzioni personali – vanno a costituire una memoria auto-valutativa, che può essere più o meno positiva o negativa. Questa memoria influenza costantemente il rapporto con noi stessi, quindi i nostri umori, giungendo ad essere il “filtro” di ogni nostra interazione con noi stessi e con gli altri.
È un alter-ego la cui ombra ci accompagna sempre.
Il rapporto con questo alter-ego è una delle imprese psicologiche più importanti della vita. Da questo rapporto dipende il nostro star bene o male in compagnia di noi stessi e il nostro giudicarci bene o male ogni qual volta interagiamo con gli altri.
L’autostima nasce innanzitutto in rapporto alla memoria transazionale interpersonale, poi si interiorizza nel rapporto che l’Io ha con se stesso, rapporto che genera una memoria auto-valutativa. La memoria transazionale e quella auto-valutativa confluiscono nella costruzione che ogni individuo si fa di una personale immagine di sé.
L’identità personale presuppone sempre una dualità: un Io osservatore e un Io osservato: dunque, un Io sociale che giudica l’Io personale, sia nei suoi atti nel mondo esterno che nei suoi più intimi pensieri. Quindi, l’immagine di sé deriva dal giudizio di valore che la parte osservante esprime nei confronti della parte osservata.
L’immagine di sé ha una formazione (una morfogenesi) “storica”, nel senso che deriva dalla memorizzazione delle esperienze attraversate nelle varie fasi della vita. E così come un genitore – o un qualunque caregiver – osserva e giudica un bambino piccolo, così come un gruppo di coetanei tratta un giovane, includendolo, escludendolo o maltrattandolo, allo stesso modo una parte dell’Io osserva, giudica e tratta il Sé, quindi gestaltizza, dà forma all’immagine di sé.
Naturalmente, possiamo assumere un linguaggio psicodinamico e dire che la personalità è sempre divisa fra diverse funzioni dell’Io; quindi, il rapporto fra Io sociale e Io personale possiamo altresì descriverlo come rapporto fra Super-io e Io.
Il Super-io è un’istanza morale innata la cui funzione è di amministrare il rapporto fra l’individuo e gli altri. Nel corso dello sviluppo individuale si riempie dei contenuti rappresentativi (i sistemi di valore e i giudizi di valore) dei genitori, degli adulti importanti e infine dell’intero mondo sociale di appartenenza. Nella versione che ne dà la Psicologia dialettica, il Super-io non è, come in Freud, l’erede del mitico complesse edipico, bensì è la funzione che implementa i sistemi di valore sociali all’interno dei sistemi di auto-regolazione psicobiologica innati.
Ciò vuol dire che se, per fare un esempio, un bambino ritiene di aver fatto del male alla madre, sia il danno arrecato alla madre che il suo proprio malessere personale vengono letti alla luce dei valori che quel bambino ha interiorizzato. Di fronte ad una propria espressione aggressiva, due bambini possono reagire in modi completamente diversi. In un primo caso, il bambino può sentirsi responsabile di un’azione lieve ed emendabile; nell’altro caso può sentirsi colpevole di una grave violazione, deducendo di essere cattivo o addirittura malvagio nell’essenza più intima della sua identità. La valutazione non dipende solo dal tipo di esperienze effettuate, ma anche e soprattutto dai giudizi di valore interiorizzati nel contesto ambientale. Nella mia esperienza clinica incontro persone che hanno subito gravi traumi infantili (abusi sessuali, percosse violente, maltrattamenti sistematici) in non più del 5% dei casi. Nella maggior parte dei casi constato “traumi cumulativi” (come li ha definiti Masud Kahn) o microtraumi relazionali protratti nel tempo, dovuti sia alla mentalità inconscia del genitore che all’azione dei giudizi di valore all’interno del bambino e del ragazzo. Un trauma esiste sempre – e sarei propenso a dire soprattutto – in funzione dell’interpretazione dei fatti che ne danno gli attori dell’azione: nel caso esemplificato, è l’interpretazione del fatto da parte sia della madre che del bambino – e di eventuali altre figure giudicanti – a determinare il grado di traumaticità dell’evento. Una madre che agisce in modo punitivo o persino persecutorio perché ritiene riprovevole l’azione del figlio o la sua stessa intima identità fa più danno di una madre che giudica l’aggressione del figlio perdonabile o persino normale in un certo contesto familiare. Lo stesso vale per gli ambienti sociali di accoglienza: non sono solo i genitori a provocare traumi; spesso lo sono le scuole, i programmi di insegnamento, le squadre sportive, i sistemi religiosi, i gruppi dei coetanei.
In sintesi, il giudizio morale è parte imprescindibile di ciò che chiamiamo “trauma psicologico”. Pertanto un’immagine di sé negativa è sempre traumatica, sia nel senso di essere il prodotto di una serie di microtraumi relazionali, sia nel senso di essere produttrice di traumi intrapsichici ulteriori. Nei miei libri ho definito “trauma autogeno” l’impatto traumatico provocato dall’immagine interna negativa sull’Io soggettivo.
Ogni qual volta ci valutiamo e ci giudichiamo al fine di regolare le nostre emozioni, i nostri pensieri e comportamenti, è il nostro Super-io che si mette in azione e giudica il nostro Io. Pertanto, se il Super-io ha assimilato giudizi negativi e valori a noi inadeguati, il nostro rapporto con noi stessi ne è condizionato. Il Super-io diventa così non solo un agente di giudizio e controllo ma anche un agente traumatico all’interno della personalità. Un nemico dentro di sé. Un vero e proprio persecutore interno.
In sintesi, dunque, l’autostima deriva, al suo livello minimo, dal rapporto fra una parte osservante, in cui si sintetizzano i giudizi memorizzati, e la parte osservata, ossia l’Io che si muove sul teatro del mondo.
L’immagine di sé, generata dall’autostima, può essere più o meno confusa e più o meno positiva o negativa; inoltre, nonostante tenda, come ogni memoria, ad autoreplicare se stessa, può essere confermata o messa in discussione dalle relazioni sociali e dalle situazioni in atto.
Storia di Luciana
 Luciana è una donna di quarantotto anni, intelligente, colta ed estremamente bella, ma che nondimeno appare ai più una creatura antipatica, narcisista, rigida, chiusa e aggressiva fino all’ostilità, tanto che ha fallito tutte le relazioni sentimentali fin qui vissute e ha perso tutte le amicizie, fino a vivere in una solitudine rancorosa e depressiva.
Luciana è una donna di quarantotto anni, intelligente, colta ed estremamente bella, ma che nondimeno appare ai più una creatura antipatica, narcisista, rigida, chiusa e aggressiva fino all’ostilità, tanto che ha fallito tutte le relazioni sentimentali fin qui vissute e ha perso tutte le amicizie, fino a vivere in una solitudine rancorosa e depressiva.
L’antipatia di Luciana dipende dal fatto che non appena si trova in compagnia si sente a rischio di subire critiche insidiose che in fondo – anche se lo ammette malvolentieri – ritiene essere veritiere; sicché, per prevenire il temuto giudizio negativo, si arrocca nel mutismo o fa battute infelici e denigratorie.
La relazione col mondo esterno è dunque la conseguenza diretta e, direi, fatale di una relazione intrapsichica negativa. Luciana è in realtà due in uno. E la parte osservante precede nei suoi giudizi qualunque giudizio esterno, rendendo pressoché impossibile una correzione dell’immagine di sé negativa mediante esperienze nuove e positive.
Il problema di Luciana nasce dall’aver interiorizzato una madre rigida e persecutoria, che ha svalutato le sue migliori caratteristiche sin dall’infanzia.
La madre è stata una donna frustrata e depressa, sia per l’origine familiare nella quale la femmina era considerata un genere inferiore, sia per l’infelice matrimonio con un uomo colto e raffinato, ma vanitoso e donnaiolo, che l’ha tradita infinite volte per poi abbandonarla. Da giovane, dunque, al momento di generare e accudire Luciana, la madre era già affetta da una depressione dovuta al suo odiare la propria condizione: il proprio essere una femmina affidata all’uomo, dipendente dall’uomo e priva di potere sociale. Sicché, nata la figlia, detestò la bambina che non solo era un’altra femmina, ma per di più la rendeva madre.
Inoltre, mentre la bambina mostrava di essere sensibile, silenziosa e introversa, lei la percepiva piuttosto come debole, inetta, sconfitta. Cominciò allora a odiare le attitudini della figlia (per esempio una precoce attitudine al disegno) giudicandole imperfette e inutili. Volle per contro che la figlia si educasse da subito ad essere bella, vistosa e altezzosa, quindi che si preparasse a “farsi pagare” dagli uomini, cioè a farsi ammirare, rispettare e ben sposare.
Quella con la quale la madre educava la figlia era una ben definita ideologia: il danno d’esser nata femmina poteva essere “corretto” dal disporre di freddezza e cinismo per la conquista di uomini adeguati, ossia ricchi e manipolabili. La vita di una femmina doveva essere mirata a questo scopo. Essere carina e gentile non serviva a nulla se non valeva a attirare i maschi; essere silenziosa era dannoso se non costituiva un fascino aggiuntivo; l’attitudine estetica aveva senso solo se intesa a ben truccarsi e ben vestirsi, in un regime di concorrenza con le altre femmine.
Luciana, dunque, sin da piccola fu costretta a sopportare due sentimenti materni costanti: A) l’odio denigratorio della madre, e B) la fantasia di ricatto con cui la obbligava ad essere seducente. Quindi venne educata a interiorizzare due basilari rappresentazioni di sé: A) il sentirsi intrinsecamente negativa, in quanto femmina vulnerabile; e B) il ritenersi perdonabile se fosse stata in grado mascherare i suoi difetti costruendo virtù fittizie atte alla conquista degli uomini.
La madre stessa ci teneva moltissimo ad essere vistosa e iperformale (una snob) ostentando una sensibilità – o per meglio dire un sentimentalismo – che nel rapporto con la figlia, nella sostanza rozzo e persecutorio, era del tutto assente. E poiché Luciana, sin da bambina, appariva il suo opposto, la denigrò nelle sue caratteristiche originarie (la mitezza, la timidezza, la vulnerabilità, la grazia, l’amore incondizionato per gli altri) e la spinse ad essere forte e competitiva, insensibile e esigente anche con se stessa, ottenendo di aumentarne l’insicurezza e la bassa autostima.
La malattia e la psicoterapia
 Divenuta adulta, Luciana si sentiva sempre sotto esame e insicura. In piscina, per esempio, si vergognava oltre ogni limite di qualche chilo di troppo. Si vedeva e si giudicava “grassa”, ossia passiva, debole, negativa (rivedendo così l’antica bambina odiosa – perché odiatadalla madre – incapace di controllarsi e di essere “vincente”). L’opinione di sé era pessima.
Divenuta adulta, Luciana si sentiva sempre sotto esame e insicura. In piscina, per esempio, si vergognava oltre ogni limite di qualche chilo di troppo. Si vedeva e si giudicava “grassa”, ossia passiva, debole, negativa (rivedendo così l’antica bambina odiosa – perché odiatadalla madre – incapace di controllarsi e di essere “vincente”). L’opinione di sé era pessima.
La madre la sorvegliava in continuazione e la sottoponeva alla sua “pedagogia nera”. La conseguenza era che Luciana acquisiva una immagine di sé sempre più negativa ed era sempre più ansiosa di correggerla. Le abitudini acquisite nello scambio con la madre la incrementavano. Costretta a incarnare, in virtù della sua straordinaria bellezza, lo strumento di vendetta della madre nei confronti degli uomini, Luciana si lasciava andare a piccole abbuffate solitarie che, facendola ingrassare e vergognare di sé, la costringevano a sottrarsi alla vista degli altri e a isolarsi. Esiliarsi in casa e deprimersi era l’unico modo che aveva per opporsi alla cinica volontà materna. Allo stesso modo evitava di coltivare la sua sottile intelligenza e le sue spiccate attitudini culturali, vissute sempre da lei stessa con diffidenza: essere intelligente poteva renderla “noiosa” agli occhi della madre e degli uomini. Sicché non leggeva quasi mai, se non libri motivazionali e di psicologia dozzinale allo scopo di modificare i suoi “difetti” ed essere “competitiva”. Non andava a teatro o al cinema se non per farsi vedere “in società”: dunque l’incontro sociale veniva adoperato come vetrina per il corpo. Frequentava gruppi di yoga e naturisti, nonché psicologi e coach motivazionali, al solo scopo di modificare i propri difetti caratteriali e le strategie perdenti e quindi “trovare un uomo”. Molte ore al giorno le passava sul divano ipnotizzata da fiction sentimentali. In sostanza, la cultura veniva adoperata più o meno come donne meno belle avrebbero adoperato la chirurgia estetica per modificare il viso e il corpo, finalizzandoli alla conquista degli uomini.
In effetti, l’apparente obbedienza di Luciana ai canoni materni celava un sottile ma costante opposizionismo: ogni indicazione o valore ricevuto veniva portato all’estremo; sicché non solo la sua sensuale bellezza veniva camuffata dai chili di troppo; ma la sua stessa innata intelligenza veniva trasformata in pigrizia e inettitudine. Nel gioco fra Super-io persecutorio e Io soggiogato si era inserito un Io ribelle – quell’Io opposizionale che la Psicologia dialettica ha definito Io antitetico – che si opponeva punto per punto ai dettami materni, senza tuttavia riuscire a formulare una coerente strategia di emancipazione.
Infine, Luciana era diventata di fatto una donna ignorante e ansiosa, impigrita e gravemente depressa, che assumeva psicofarmaci e passava gran parte del tempo libero di fronte al televisore, dove trova confermati i modelli più superficiali di seduzione e successo, ricavandone ulteriore depressione.
Per gran parte della sua vita Luciana aveva mantenuto fra sé e sé il filtro dell’immagine interna negativa, e infatti era divenuta sin da ragazza una persona risentita e depressa. Ma anziché continuare a sentire dentro di sé, come parte del sé, questo Super-io giudicante rivolto contro il suo potenziale originario, faceva qualcosa di molto più insidioso: per soffrire di meno, proiettava sulla gente il giudizio negativo (lo esteriorizzava e lo generalizzava) e proiettava su figure maschili idealizzate l’ideale narcisistico (ossia ciò che lei stessa avrebbe voluto essere), sicché, da una parte si sentiva sempre a rischio di essere maltratta dall’ambiente, da qualunque ambiente; dall’altra desiderava l’“Uomo perfetto”, giovane, palestrato, ricco, cinico, di successo, che sapesse difenderla dal giudizio del mondo che sentiva univocamente negativo.
Dopo qualche insuccesso sia con gli uomini, che si sentivano soffocare dalla sua dipendenza, sia sul lavoro, dove veniva criticata per il suo isolazionismo, la sua tendenza polemica e la scarsa attitudine al sacrificio, sviluppò una psicosi paranoide. Il delirio – durante il quale si diceva osservata e perseguitata da gente malevola – durò un paio di mesi; poi sfumò così come era venuto. Ma lasciò una lunghissima scia fobica e depressiva. Io la ricevetti per la prima volta all’avvio del delirio, la seguii nel decorso, poi la coinvolsi in una psicoterapia che la accompagnò per circa due anni.
In terapia analizzammo le sue dinamiche più evidenti. Per esempio quella con gli uomini.
Con gli uomini Luciana negava la propria sensibilità e introversione idealizzando la possibilità di far innamorare un uomo estroverso, superficiale, cinico e di successo, sicché l’eros era finalizzato interamente alla conquista e al controllo di quest’uomo. Dunque, inibita nell’essere sensibile e qualitativa, la vita sentimentale di Luciana era forzata ad essere strumentale. Con la strategia della conquista Luciana mirava a sedurre e controllare il suo giudice interiore – quella persona “forte” che lei stessa avrebbe voluto essere –, quindi si disponeva a ingannarlo e addomesticarlo.
Purtroppo, nel tentare questa strategia Luciana si sentiva indegna due volte: primo perché si ammetteva debole, passiva e servile nei confronti dell’uomo; secondo perché era costretta ad essere falsa e ingannatrice, quindi malvagia. Odiando il suo personaggio e in fondo anche il tipo d’uomo cui si rivolgeva, faceva delle gaffes, si rendeva goffa e antipatica, si sabotava. In sostanza veniva giocata come una pallina di pingpong fra il Super-io che la giudicava inetta e l’Io antitetico che lo sabotava: prima si sottometteva e poi si ribellava, prima faceva la gattina e poi la tigre in gabbia. Alla fine, l’uomo, esasperato, la lasciava. Il risultato ultimo di questa drammatica dialettica era la sconfitta, la solitudine e la condanna.
Alla fine Luciana tornava sempre sola con la madre.
In un paio d’anni di psicoterapia Luciana si liberò degli spunti deliranti, per fortuna occasionali, e della grave e persistente depressione. Il mio lavoro di psicoterapia con lei consistette, nelle sue linee essenziali, nel mostrarle le parti opposte della personalità: la parte giudicante e la parte giudicata. Quindi, la aiutati a riportare la parte giudicante alla sua genesi storica: il rapporto con la madre e l’interiorizzazione di valori denigratori e spregiativi da un lato e vendicativi, aggressivi e competitivi dall’altro; valori ad alto potenziale stressogeno e patogenetico. L’aiutai inoltre a riportare la parte giudicata ai suoi positivi caratteri originari: la sensibilità, l’introversione, l’iperdotazione nella bellezza fisica, nell’intelligenza emotiva, estetica e nella creatività, tutti caratteri repressi dal giudizio negativo e deviati verso fini utilitaristici.
Dopo circa un anno di lavoro, ogni rischio psicotico era scongiurato; dopo due anni, uscita dalla depressione e scoperta una nuova autostima, poté emanciparsi dalla madre e considerarsi guarita.
Un esempio di buona autostima
 In conclusione e in modo del tutto leggero, vorrei suggerire cosa è l’autostima e indicare come esempio di buon rapporto con se stessi l’arte di Marc Chagall, pittore ebreo russo divenuto francese di adozione.
In conclusione e in modo del tutto leggero, vorrei suggerire cosa è l’autostima e indicare come esempio di buon rapporto con se stessi l’arte di Marc Chagall, pittore ebreo russo divenuto francese di adozione.
La pittura di Chagall è un esempio di buona relazione intrapsichica: egli esterna nella pittura il suo Sé profondo: il paese d’origine, Vitebsk, l’umiltà ebraica contadina, le scene di una vita da villaggio di provincia, ma anche l’orrore dei pogrom, la tristezza della diaspora… Spicca fra tutti il tema dell’amore per la moglie, il tutto con verità, trasparenza, senza finzione e vergogna, senza odio per i nemici, direi con amore verso la vita.
Bibliografia
Per capire più a fondo la psicodinamica dell’autostima e dei suoi crolli depressivi, sia su un piano teorico che attraverso storie cliniche:
Ghezzani N., Volersi male, FrancoAngeli, Milano, 2002.
Ghezzani N., La logica dell’ansia , FrancoAngeli, Milano, 2008.
Ghezzani N., A viso aperto, FrancoAngeli, Milano, 2009.
Ghezzani N., Persone sensibili in terapia , FrancoAngeli, Milano, 2022.
Per capire come i codici di competizione contemporanei inducano dipendenza e ansia da prestazione:
Oliver James, Il capitalista egoista, Codice edizioni, 2009.
Per informarsi su quanto sia potente la persuasione occulta circa i trattamenti di bellezza nel mondo contemporaneo:
Laura Bruzzaniti, Il trucco della bellezza, Nuovi Mondi editore 2009.