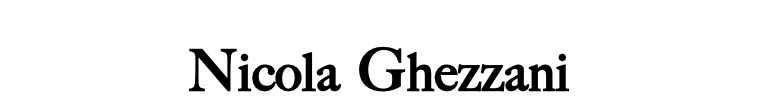Anne Tyler e Maeve Brennan
Due scrittrici a confronto
Pro e contro la letteratura “globale”
Sul “feticismo letterario”
 Negli ultimi dieci anni nel mondo del libro si è assistito a un fenomeno impressionante quanto a potenza e vastità. Mi riferisco alla parziale scomparsa delle letterature “locali” a favore di una enorme, onnivora letteratura “globale”.
Negli ultimi dieci anni nel mondo del libro si è assistito a un fenomeno impressionante quanto a potenza e vastità. Mi riferisco alla parziale scomparsa delle letterature “locali” a favore di una enorme, onnivora letteratura “globale”.
Per letteratura globale intendo una letteratura che anche laddove si esprima nelle lingue locali (italiano, russo, cinese…) è di fatto pensata e composta sulla base della struttura linguistica e tematica dei libri di maggior successo di mercato. Da molti decenni i best-seller sono più o meno tutti di matrice culturale americana; sicché le letterature locali non solo imitano i temi della pubblicistica americana (dal thrilling con annesso serial killer al manuale di self help, dalla scrittura minimalista al plot per sceneggiatura), ma adottano più o meno consapevolmente la struttura linguistica di base dell’inglese commerciale, una lingua universale dotata di un dizionario di non più di cinquecento vocaboli e di strutture sintattiche poco più che elementari.
Lode al mercato, naturalmente, che ha il merito di aver portato alla lettura centinaia di milioni di persone altrimenti condannate all’angusta dimensione della cultura orale o, peggio, di quella televisiva. Ma anche maledizione al mercato, perché l’immenso appiattimento della produzione di pensiero (sia delle rappresentazioni che dei concetti) di questi ultimi anni è in gran parte opera sua.
La letteratura somiglia ormai sempre più a un intrattenimento generico e astratto che non interroga in profondità le radici delle questioni umane (che sono locali, “territoriali”, come ogni radice), e non le interroga nel lessico e nell’idioma caratteristici di quelle questioni. Questa moderna letteratura ci “connette” col mondo delle rappresentazioni collettive globali (adeguandoci a un concetto restrittivo di “umanità”) con lo stesso movimento con il quale ci separa dalla ascendenza storica, genealogica, dell’umanità così come si è depositata nei secoli e nei millenni in ciascuna società particolare.
Un interessante critico italiano, in verità uno dei più dotati di vis polemica delle ultime generazioni, Carla Benedetti, ha così sintetizzato in un intervento su un sito (poi riportato sul settimanale L’Espresso), la sua riflessione in proposito:
Genocidio1
Questo meccanismo, semplice e micidiale, è stato chiamato «censura del mercato»: un’espressione efficace per dire che oggi certi libri subiscono una repressione analoga a quella dei regimi, anche se esercitata con parametri non più direttamente ideologici ma di mercato. Tutto questo fa impallidire il vecchio concetto di «industria culturale» coniato da Adorno e Horkheimer nel 1947. Questa nuova macchina che va a caccia solo di libri destinati alla lista dei bestseller, e del nome noto da pagare con anticipi vertiginosi, provocando la rovina di editori prima in attivo (un po’ come è accaduto alle società sportive fallite per i prezzi drogati dei calciatori), questa industria “mutante” che entra, salassa e fa il deserto, dovrebbe piuttosto essere chiamata industria del genocidio culturale.
Anche la distribuzione è mutata di conseguenza. Le piccole librerie “intelligenti” soccombono: al loro posto grandi catene organizzate per lo smercio veloce dei bestseller, occupate militarmente da valanghe di libri seriali, uccidono i libri di cultura, dal ciclo più lento. Tutto questo sta oggi accadendo anche in Italia. E con effetti forse ancor più devastanti che nel mercato anglosassone, che, essendo molto più vasto, consente margini di manovra e maggiore diversificazione.
Succede poi in Italia anche un altro fatto allarmante. La monocultura non viene più praticata solo dall’editoria controllata dai grandi gruppi ma si è estesa trasversalmente, contagiando anche l’editoria indipendente e “di sinistra”.
Giustissimo. Oggi possiamo leggere best-seller americani cha fanno da battistrada a best-seller (o aspiranti tali) italiani, francesi, svedesi, i quali hanno le stesse identiche caratteristiche dei primi, ma con in più un drammatico impoverimento lessicale, sintattico e testimoniale rispetto ai primi, come avviene di regola per ogni copia nei confronti del suo originale. Egualmente, possiamo leggere in italiano best-seller algerini, russi o cinesi che sono “mercantili” di fatto, adeguati allo stolido linguaggio universale, pur dietro una parvenza di localismo letterario. Si crea così un circuito di rimandi – e di acquisti – che vorrei definire feticismo letterario globale in assonanza col concetto di «feticismo delle merci» di marxiana memoria.
È ovvio che un bacio d’amore dato a Tel Aviv da due giovani che hanno visto morire dei compagni in un attentato è del tutto diverso da un bacio d’amore dato a Roma in un giardino dei Parioli o a Parigi passeggiando sotto casa sugli Champs-Élysées. Così come è impensabile che la sintassi di una frase smozzicata, tagliata, pronunciata da un investigatore di New York o di Chicago, magari negli anni ’40, sia la stessa di un investigatore catanese che indaga a Milano o a Canicattì. O che in un romanzo thrilling si possa descrivere un fenomeno di mafia come se fosse una gang di New York o la malavita di Marsiglia. Così come è pazzesco presentare una madre iraniana con le stesse tinte di una Sophia Loren in salsa hollywoodiana che impersona una madre greca con mosse napoletane.
Tutto in questa letteratura di consumo globale risulta irrimediabilmente falso. Non a caso il lavoro letterario, mentre si candida a divenire un best-seller sul mercato librario, è allo stesso tempo pensato e scritto in linguaggio visivo cinematografico, con le stesse ricette “a buon mercato”: la creazione di personaggi globali, figurine ritagliate in carta da rotocalco adatte ad ogni popolazione di consumatori, e uno svolgimento della storia identificabile per generi. Il falso letterario si declina allora secondo stili e clichériconoscibili e smerciabili come “luoghi comuni” e “parole d’ordine”, che sembrano indicare le vie di una illusoria integrazione nel villaggio globale, ma sotto i quali si avverte piuttosto il sibilo continuo, il rumore di fondo dell’angoscia. La sensazione di una minaccia di annientamento cui non si riesce a conferire senso e a dare parola.
Fra parentesi direi che ciò che vale per la letteratura vale anche per la divulgazione scientifica, soprattutto in materia di psicologia. Accennavo prima ai manuali di self help o comunque di psicologia pratica di origine americana: in questi manuali, poi fedelmente ricopiati in opere “originali” da solerti amanuensi italiani, incontriamo una psiche destorificata, delocalizzata, astratta, e di conseguenza rimedi che non possono rimediare niente, essendo egualmente astratti e destorificati. Si tratta di libri che vendono moltissimo, ma che alla fine aprono la porta – quantomeno per disperazione – all’unico prodotto globale che sortisca un qualche pur debole effetto: il farmaco.
In questo campo abbiamo – proprio in virtù dell’esistenza di libri costruiti sul modello del format televisivo – autori che ricalcano in modo pedissequo labili personalità mediatiche cui più che il titolo di psichiatra o psicologo si attaglia la definizione di comunicatore. E abbiamo la smodata proliferazione di libri d’occasione, nati pensando a un argomento di moda (la depressione, l’attacco di panico, la psicologia dei serial killer, la crisi dei trent’anni…) e composti da un giorno all’altro con la tecnica del “taglia e incolla” allo scopo di occupare un campo discorsivo o di vendere qualche copia in più rispetto all’odiato rivale.
Anche in questo campo, così come non esiste quasi più, nemmeno tra gli psichiatri, nemmeno fra gli psicologi, l’idea di cosa sia la grande psicopatologia (nessuno la legge, nessuno la studia, nessuno – e ciò è molto più grave – ne sente più il bisogno…), abbiamo altresì perso la lucidità e la passione necessarie per leggere e circostanziare autori fatali come Freud e Jung, Kraepelin e Bleuler, Jaspers e Laing, Reich, Adorno e Erich Fromm, Janet e Charcot, Clérambault e Lacan, William James, Melanie Klein e Donald Winnicott in quanto grandi classici nati nella storia della loro cultura e della loro società. Allo stesso titolo (direi con la stessa confusa e presuntuosa ignoranza) non abbiamo nemmeno l’idea che ci possano essere autori italiani, di quelli seri e studiosi e realmente calati nella realtà locale, in grado di produrre psicologia e psicoterapia di altissimo livello.
Per dare un mio contributo alla discussione, fornisco qui di seguito due mie critiche letterarie: una contro un prodotto da “feticismo letterario globale”, l’altra a favore di un romanzo di una potente – e scomparsa – scrittrice irlandese. Mai come oggi occorre avere il coraggio di prendere posizione. Diversamente, si finirà tutti per far parte di quella marmellata del compromesso che caratterizza l’atmosfera culturale contemporanea.
Anne Tyler «Il tuo posto è vuoto» (racconti, editore Guanda, anno 2005)
 Al mondo esistono milioni di libri. Molti sono inutili. La raccolta di racconti di Anne Tyler Il tuo posto è vuoto è uno di questi. Si tratta di un libro perfettamente inutile, scritto con fresca e ariosa leggerezza (le 140 pagine della versione italiana si leggono in non più di tre ore), in uno stile semplice e diretto, da school writing. Descrive vite prive di spessore, attenuate nei toni, tutte appiattite su uno sfondo che le rende omogenee come una marmellata di frutti misti.
Al mondo esistono milioni di libri. Molti sono inutili. La raccolta di racconti di Anne Tyler Il tuo posto è vuoto è uno di questi. Si tratta di un libro perfettamente inutile, scritto con fresca e ariosa leggerezza (le 140 pagine della versione italiana si leggono in non più di tre ore), in uno stile semplice e diretto, da school writing. Descrive vite prive di spessore, attenuate nei toni, tutte appiattite su uno sfondo che le rende omogenee come una marmellata di frutti misti.
Prendiamo il primo racconto, che dà il titolo alla raccolta. Una madre iraniana va a trovare il figlio medico negli Stati Uniti, dove ha sposato una semplice e incisiva ragazzona americana e ha avuto una figlia. L’anziana donna sembra rispondere, nella penna monocorde della Tyler, allo stereotipo cinematografico della “mamma mediterranea” o più genericamente della “mamma di un paese sottosviluppato”. Ovviamente è superstiziosa, ovviamente ha uno scialle in testa che si toglierà in un momento di gioiosa emancipazione, ovviamente cucina bene e dà ottimi consigli per l’accudimento e la salute della bambina. Purtroppo (anche qui come da copione hollywoodiano) si dimostrerà ossessiva e invadente nelle faccende domestiche e familiari fino a provocare la tacita ostilità della nuora, scavalcata nel suo ruolo, il fastidio del figlio, preoccupato per l’equilibrio della sua vita familiare, e infine l’educato ma fermo allontanamento da parte di questo e l’inevitabile rientro anticipato in Iran.
La donna, nonché iraniana, potrebbe essere allo stesso titolo greca, italiana, bulgara o spagnola. O magari – alla prossima puntata – cinese. Il copione è sempre lo stesso.
Il racconto (ripubblicato in Italia nel 2005) è del ’75 e non brilla di alcuna preveggenza. Perché la Tyler sta parlando di emigrazione iraniana negli Stati Uniti d’America in un’epoca in cui vigeva in Iran il regime filo-occidentale dello shah Reza Pahlevi, sovrapposto con la forza a una base sociale musulmana nazionalista e tribale. Di tutto questo nel racconto della Tyler non si avverte nemmeno l’odore. Ma se uno scrittore non sente puzzo di zolfo nemmeno all’inferno è lecito domandarsi che utilità possano mai avere i suoi scritti.
Nei due lunghi racconti iniziali della raccolta (Il tuo posto è vuoto e Zio Ahmad), entrambi dedicati all’emigrazione iraniana negli Stati Uniti, si parla di vaghe disarmonie culturali, superabili in una o due generazioni – nulla che lasci prevedere, e nemmeno intuire, l’imminente avvento della rivoluzione khomeinista, avvenuta nel ’79, che diede l’avvio alla teocrazia iraniana, il primo vero integralismo islamico di marca nazionalista del ventesimo secolo, minaccioso e bellicista quanto e più dei coevi movimenti palestinesi dell’OLP e di Al Fatah.
Nella nostra storia recente, tuttavia, abbiamo visto cosa può accadere a taluni della seconda e terza generazione di immigrati da culture islamiche: uomini (mai donne), talvolta sposati con donne occidentali, che tornano a radici mai abbandonate, col sogno di gettare gli “infedeli” nel fuoco dell’inferno. Ebbene, uno scrittore non dovrebbe aiutarci a percepire e capire la vita nelle sue emergenze più acute e più forti? Non dovrebbe aiutarci a pre-vedere la storia?
Al contrario, l’effetto che ci dà un libro come questo della Tyler è di una buona prova, di una certa eleganza, di ciò che definirei provincialismo globale: la pretesa che la verità del mondo possa essere ridotta al manierismo dell’intrattenimento, dell’arte intesa come grande calmante collettivo.
Allora, di fronte a prove letterarie di questo genere, come non provare nostalgia per un romanzo come I demòni di Fëdor Dostoevskij, che – pur essendo stato scritto nel profondo ottocento – ci illumina e ci informa ancor oggi sul nichilismo dei movimenti mistico-rivoluzionari passati, presenti e futuri? Il paragone è arrischiato. Che senso ha scomodare – per così piccoli scopi – il povero, grande Dostoevskij? In fondo, Anne Tyler, col suo stile semplice e diretto, con i suoi personaggi quieti e prevedibili, non ha mire tanto elevate: il suo scopo è di riempire il tempo in giornate monotone consumate fra la torta di mele e il ritorno del marito, fra la telefonata dell’amica e lo shopping “etico” al negozio di aromi orientali. Nulla di più, nulla di meno. Il suo scopo ultimo è, in fondo, la consolazione.
La sensazione di essere capitati in un libro della new wave del provincialismo globale è poi confermata dal quarto racconto della raccolta: Il bernoccolo delle lingue, nel quale la giovane donna americana – questa volta – è sposata neanche a dirlo proprio con un italiano. Il giovanotto, professore universitario di italiano e, appunto, col bernoccolo delle lingue, è una sagoma buffa e anonima come la mamma e lo zio iraniano dei racconti precedenti: ha melodrammatiche sorelle molto ciarliere, e, ovviamente, grasse zie mediterranee esperte in cucina e impegnate in interminabili pettegolezzi sulla numerosissima famiglia. Noia assoluta del lettore di fronte al senso di inadeguatezza della scialba mogliettina.
Solo nel terzo e nel quinto racconto, di ambiente del tutto provinciale e del tutto americano, rispettivamente su una madre che abbandona il figlio disabile mentale in un lindo e anonimo cronicario, e su una giovane moglie che preferisce – senza riuscire ad ammetterlo – il baldo meccanico d’auto unto di grasso al marito goffo intellettuale, la Tyler si riscatta e sale di qualche misura: conosce l’intima frustrazione della casalinga americana meglio di quanto non conosca la per lei irraggiungibile estraneità del mondo. Nell’ardimento estremo di guardarsi allo specchio e di sognare l’avventura ciò che di meglio l’io narrante possa qui fare è riconoscersi – ma per misconoscersi – nel gemito inarticolato di un idiota, e di auspicare una ordinaria manutenzione per i semplici meccanismi a trazione cui è ridotto, con la propria anima, lo stesso pallido plotnarrativo.
Qui, in questi due racconti americani, non c’è consolazione che tenga. E tuttavia, non rifiutata, né schivata, né messa in parodia, una coscienza illuminata – da vero scrittore –, che porti infine i personaggi di una storia sul registro del tragico o del grottesco, nelle pagine di questo libro purtroppo non si vede: né dentro né fuori. Né dunque nello stato presente di questa scrittura né, presumiamo, nel suo ravvisabile futuro.
Maeve Brennan «La visitatrice» (Romanzo, editore Rizzoli BUR, anno 2005)
 Ogni anno nel mondo si riversano sui banchi delle librerie centinaia di migliaia di volumi di libri (sia di nuova creazione che riedizioni di vecchie opere) in una profusione smisurata, tanto ammirevole quanto ubriacante. La più parte di essi è del tutto inutile, e fa male al cuore pensare a quanti milioni di metri cubi di foreste vengano sacrificati sull’altare della buia futilità consumistica, la quale, più si espande, più spalanca il vuoto della labile e superficiale coscienza contemporanea (stante il fatto che sono ancora pochi, purtroppo, gli editori che, coscienti dei loro limiti, si siano impegnati a pubblicare su carta riciclata o sintetica).
Ogni anno nel mondo si riversano sui banchi delle librerie centinaia di migliaia di volumi di libri (sia di nuova creazione che riedizioni di vecchie opere) in una profusione smisurata, tanto ammirevole quanto ubriacante. La più parte di essi è del tutto inutile, e fa male al cuore pensare a quanti milioni di metri cubi di foreste vengano sacrificati sull’altare della buia futilità consumistica, la quale, più si espande, più spalanca il vuoto della labile e superficiale coscienza contemporanea (stante il fatto che sono ancora pochi, purtroppo, gli editori che, coscienti dei loro limiti, si siano impegnati a pubblicare su carta riciclata o sintetica).
Alcuni libri, tuttavia, sono vere e proprie gemme – tali da riscattare da soli il grigiume diffuso dell’intera produzione. Una di queste gemme è il libricino pubblicato dalla BUR (Rizzoli) che disseppellisce e porta alla luce un romanzo breve di Maeve Brennan.
Scrittrice irlandese emigrata negli Stati Uniti che pubblicò in vita solo un paio di raccolte di racconti (purtroppo ancora inedite in Italia) Maeve Brennan condusse una ben strana esistenza. Visse, infatti, come il personaggio di quel meraviglioso racconto di Melville che è Bartleby lo scrivano, aggrappata, con le unghie e con i denti, alla redazione della rivista letteraria per la quale lavorò, il famoso New Yorker. Dipendente dal luogo fisico, dai locali, della redazione, la Brennan campò come una barbona di lusso nell’ambiente dei letterati (ignara del motto di Adorno che sentenzia – giustamente – che lo scrittore consapevole sa, alla fine, di essere estraneo a qualunque luogo fisico, a qualunque rifugio, e di essere pertanto un esule ovunque, anche da quel paese fatto di parole che è la scrittura). Ammalata nella psiche, fu senza dimora, e abitò – col consenso dei colleghi – nella toilette degli uffici della redazione. Fino al ricovero in clinica psichiatrica, dove poi la morte la colse.
Lasciò un romanzo inedito, che è appunto, La visitatrice, romanzo breve o racconto lungo (un novelpsicologico) di un centinaio di pagine dove si narra il ritorno di una giovane irlandese a Dublino, a seguito della morte della madre con la quale ha vissuto per molti anni a Parigi. Il ritorno è in casa sua, la casa del padre – anch’egli morto da lungo tempo – che le spetterebbe per diritto ereditario. La casa, tuttavia, è abitata dalla vecchissima nonna paterna, che, come una strega da favola dell’orrore o come un personaggio di Elsa Morante (che è quasi la stessa cosa) esprime nei suoi confronti, sin dalle prime pagine, una terribile condanna: poiché all’epoca della separazione fra i genitori la ragazza scelse la madre e fuggì con lei a Parigi abbandonando il padre (il figlio della vecchia) il quale a suo dire morì dal dolore, ella non può più meritare alcuna accoglienza. Che muoia dunque esule come ha voluto vivere. La ragazza, inerme e spaventata, prova ad obbedire alla condanna, ma nell’ultima terribile scena, dopo aver simulato la partenza, la si vede accamparsi sotto le finestre della vecchia in preda a un delirio.
Difficile non vedere nell’epilogo della storia l’avventura di scrittori come Joyce o Beckett che in esilio dall’Irlanda vissero più che bene; e, per altro verso, la sventura della Brennan che in un esilio che avrebbe potuto essere non meno dorato scelse la via dell’autocondanna, della miseria psichica e della follia. Quasi a confermare – a più duemila anni di distanza – che l’eroe del viaggio che inaugura la letteratura occidentale, Ulisse, è un uomo e che alla donna che si avventuri sulle stesse vie tocca ancora l’atroce dispersione nel mare della follia.
Il romanzo è un piccolo capolavoro di letteratura d’ambiente, nel quale i paesaggi della natura sono interamente trasfigurati in quelli obliqui e inquieti della mente.
La Brennan è stata accostata a due stelle maggiori del firmamento letterario: a Emily Dickinson e al Joyce dei Dubliners. Io la vedrei con più aderenza a fianco alla prima, per la sottile notazione dei sentimenti nascosti, e appunto a Elsa Morante (di cui l’irlandese fu lettrice e estimatrice) per la trasfigurazione metaforica, favolistica (da storia gotica o dark) dei pochi e abbozzati personaggi.
Nicola Ghezzani
Psicologo clinico, psicoterapeuta
formatore alla psicoterapia
Contattalo con un messaggio su WhatsApp al 333 999 4797
o per e-mail: nic.ghezzani@gmail.com
Indirizzo Skype: nicola.ghezzani.psicologo
- Carla Benedetti, su Nazione Indiana, 18/01/2005.